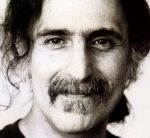Inizio giugno 1972: esco da scuola, ero agli ultimi giorni di terza media, e mi precipito a Villa Pamphili dove si teneva il festival rock omonimo. Si chiamava ancora Caracalla Pop, in omaggio al luogo in cui l’anno precedente si era tenuta la prima, leggendaria edizione.
I gruppi iniziarono ad avvicendarsi sul palco già dalle prime ore del pomeriggio, malgrado la luce abbagliante e il caldo non favorissero la presenza scenica e forse neppure le esecuzioni. Tra quelli che si esibirono prima del tramonto i più noti erano forse i Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, allora andavano i nomi lunghi, e Quella Vecchia Locanda. Poi il presentatore Eddy Ponti annuncia i Blue Morning.
La loro musica catturò la mia attenzione in maniera ben più pressante: già allora il jazz rock mi piaceva molto, più di tutto il resto. D’altronde era la musica d’avanguardia di un periodo rimasto d’avanguardia fino a oggi, mezzo secolo dopo, e chissà per quanto lo rimarrà ancora.
Malgrado lo spazio concesso a ogni gruppo non fosse moltissimo, forse un tre quarti d’ora ciascuno, l’esibizione dei Blue Morning mi rimase impressa, malgrado non sapessi assolutamente chi fossero Maurizio Giammarco e Roberto Ciotti, che d’altra parte erano agli inizi della loro carriera.
Così quando alcuni anzi diversi mesi dopo, se non ricordo male era quasi la primavera del 1974, in una delle mie allora frequentissime incursioni presso un negozio di dischi, i pochi soldi che riuscivo a racimolare li spendevo così e per andare ai concerti, m’imbattei in un LP dalla copertina che definire minimale è ancora poco. Era proprio quello dei Blue Morning, distribuito in pochissime copie dalla Tomorrow, etichetta della RCA dedicata ai talenti emergenti.

Sul retrocopertina, tra le altre, c’era la foto di Giammarco presa sul palco del festival, come riconobbi all’istante. Ulteriore motivo che mi spinse ad acquistarlo.
Per la cronaca, gli LP costavano 3500-3700 Lire. Oggi sembra niente ma allora non era poco: ogni disco acquistato era il frutto di un sacrificio. Almeno per me.
Talmente raro è quel disco che a quanto mi consta alcuni dei listini dei dischi da collezione non lo considerano proprio. Non che stia a consultarli più di tanto, dato che per me il disco vale per il piacere che può dare all’ascolto e non per la carta straccia che si può recuperare cedendolo, almeno fin quando non morirò di fame. E anche allora ci penserò, prima di separarmi dai miei cimeli.
E’ da capire se la sua assenza si debba appunto alla reperibilità peggio che difficoltosa o perché non viene considerato vero prog, genere rispetto al quale la richiesta delle stampe d’epoca è maggiore e tale viene ritenuto anche il loro interesse.
Sia come sia, tengo qui a precisare con un certo orgoglio che le immagini che girano in rete di quel disco sono proprio della copia in mio possesso. A suo tempo ne ho fatto omaggio a non so a quale sito specializzato di rock progressivo e da li sono state riprodotte più volte.

Panini volanti è appunto il titolo di uno dei brani inclusi nell’album dei Blue Morning, tra l’altro composti da un Giammarco allora giovanissimo quasi per la loro totalità, che mi è piaciuto prendere a prestito per il titolo di questo articolo-intervista.
A titolo di curiosità in quell’album Giammarco oltre ai sassofoni suona il pianoforte e il Fender Rhodes, a livello tuttaltro che episodico e anzi con un tocco e un gusto proprio niente male. Poi ha continuato con il sassofono ma da quel che si ascolta avrebbe potuto tranquillamente fare anche il tastierista.
Dedichiamo un istante ancora alla Tomorrow, etichetta che oltre all’album dei Blue Morning ne ha pubblicato solo un altro, “Sud” di Mario Schiano, combinazione anch’esso presente nella mia raccolta. Giammarco vi figura in un paio di brani se non vado errato, insieme alla crema dell’allora nuovo jazz italiano, costituita da gente come Massimo Urbani, Roberto Della Grotta, Toni Formichella e così via. Insieme a loro musicisti del calibro di Bruno Tommaso, contrabbasso, Tommaso Vittorini, sax, Afonso Vieira, batteria, Mandrake, percussioni.
La Tomorrow era una creatura di Vincenzo Micocci, proprio il Vincenzo che Alberto Fortis giurava di voler ammazzare in uno dei suoi brani più famosi, si dice perché rifiutò di fargli registrare un disco o comunque diede parere negativo a un suo provino.
Il progetto Tomorrow era molto interessante ma purtroppo ebbe vita breve. Sorte comune anche ai Blue Morning, sia pure per altri motivi, come spiegherà tra qualche riga Maurizio Giammarco. Lo voglio ringraziare per la disponibilità mostrata nel concedermi questa intervista.

Maurizio è uno tra i sassofonisti italiani più noti e di maggior esperienza e carisma, che spazia oltretutto in un’ampiezza di ambiti poco comune, proprio a iniziare dal rock progressivo riguardo al quale ha fatto parte di uno dei progetti di maggior prestigio dell’intera sua storia: l’album Carnascialia. Ha suonato inoltre jazz, nei contesti più disparati, anche a livello internazionale, e jazz elettrico. Impossibile non menzionare a questo proposito il gruppo Lingomania.
Oggi Maurizio opera con il suo gruppo, Syncotribe, con cui esegue una musica che dal mio punto di vista è una sintesi efficace delle sue numerose esperienze e soprattutto non è catalogabile con precisione entro una corrente jazzistica riconosciuta a livello più o meno ufficiale. Questo mi piace parecchio ed è quanto sono riuscito a capire da una sua esibizione dal vivo cui ho potuto assistere, ormai qualche anno fa, nel contesto di una rassegna tenutasi ai giardini del Gianicolo, a Roma.
Insieme a Giammarco erano sul palco Luca Mannutza, tastiere, ed Enrico Morello alla batteria.

Non indugiamo oltre e andiamo all’intervista con Maurizio, che almeno a mio parere ha raccontato cose parecchio interessanti. Soprattutto per chi insieme alla musica apprezza la conoscenza di quel che accade lontano dal palco.
L’intervista
Se possibile, con le mie domande partirei dagli inizi, quindi chiedendoti com’è nata la collaborazione con Roberto Ciotti che ha portato al formarsi dei Blue Morning.
I Blue Morning esistevano da prima. E’ stata una vera e propria garage band con la quale abbiamo imparato a suonare alla fine degli anni 60. Nel 70 c’era ancora Billy Ward, già pianista dei Folkstudio Singers, che per primo suonò il Fender Rhodes dalle nostre parti e poi partí per l’Australia (mai più saputo nulla di lui). In effetti Ciotti riempì poi questo vuoto. Ho ascoltato Roberto per la prima volta a un festival rock in un teatro che non ricordo (forse il cinema Reale a Trastevere?) Nel 70 o nel 71, non saprei. Roberto mi folgorò immediatamente perché suonava il blues come nessun altro in Italia, e io sono cresciuto ascoltando jazz e blues. Con una certa faccia tosta gli proponemmo subito di collaborare e andò bene. Con l’entrata di Roberto, della vecchia formazione restammo solo io e Alfredo Minotti (batteria). Al basso arrivò Sandro Ponzoni che se non ricordo male fu suggerito da Roberto stesso.
Se quella viene ricordata non senza ragione come la fase eroica del rock italiano, figuriamoci quale poteva essere la realtà per formazioni come i Blue Morning, che avevano scelto la strada della sperimentazione, sia pure in un contesto di fruibilità, e dell’apertura verso il jazz. Puoi descrivere le tue impressioni del periodo o magari hai qualche ricordo che aiuti a comprenderne meglio il significato e l’insegnamento che ne è derivato?
Si suonava dove capitava, in tutti i sensi. Mi ricordo giorni interi passati con gli ampli in macchina alla ricerca di un posto dove provare. Io frequentavo già l’ambiente del jazz romano e capitò di suonare in qualche festivalino autogestito e al Folkstudio, cosa che ci diede un po’ di esposizione sulle fanzine dell’epoca. Musicalmente ero allora più interessato ai gruppi di jazz rock. Non eravamo ancora cosí bravi per fare quella musica, ma io andavo comunque in quella direzione, sicuramente più degli altri. Infatti il gruppo ebbe vita breve, Roberto cercava una sua direzione.
Malgrado le loro indubbie potenzialità, al primo LP i Blue Morning non hanno dato un seguito. Eppure quello era un periodo favorevole per i gruppi alla ricerca di una sintesi tra linguaggi diversi, definiti jazz-rock: basta guardare a Nucleus e Soft Machine, tanto per fare due tra gli esempi più ovvi, o anche agli Area. Puoi spiegare i motivi? Quale poteva essere una possibile evoluzione per la musica del gruppo?
Eravamo giovani. Quando abbiamo registrato il disco, nel ’72, io avevo 20 anni e Roberto 19. Non c’era una visione programmatica di chissà quale livello. Personalmente cercavo di portare il gruppo in quella direzione (jazz rock), in quanto il mio background è sempre stato jazzistico, ma in fondo suonavamo quello che semplicemente usciva fuori. Infatti dal 1973, finita l’esperienza del gruppo, sono entrato nel giro del Free Jazz romano.
Blue Morning ha sperimentato la formula riguardante l’innesto di un chitarrista blues in un gruppo jazz, utilizzata diversi anni dopo da pesi massimi come gli Yellowjackets, quantomeno nella loro formazione d’esordio, forse la più fortunata. Quali sono le tue valutazioni al riguardo?
Semplicemente tutta questa musica di cui stiamo parlando parte dal blues, e se io non avessi incontrato il blues, da molto giovane, forse non avrei neanche fatto il musicista.
L’album dei Blue Morning è uscito per l’etichetta Tomorrow, che ha pubblicato solo un altro disco, quello del sassofonista Mario Schiano, intitolato “Sud”, in cui figuri anche tu, insieme a una vasta rappresentanza di quello che allora si poteva considerare il nuovo jazz italiano. Come valuti il progetto di quell’etichetta, soprattutto in funzione della realtà di quel periodo e delle sue potenzialità quale mezzo atto a favorire l’espressione e la visibilità delle nuove leve?
Fu un progetto di Vincenzo Micocci, il talent scout che inventò il termine “cantautore”. Era una persona di grande cultura e di ampie vedute, ma non così ampie da continuare a perdere soldi.
Passiamo alla fase finale dell’epoca d’oro del prog italiano per parlare di Carnascialia. E’ stato un progetto ambizioso che per tanti versi ha costituito la summa delle esperienze condotte fino a quel punto. Nell’album omonimo l’apporto del folk e della musica etnica, anche se allora non si chiamava ancora così, assume un ruolo significativo e a questo riguardo una valutazione da parte tua sarebbe molto interessante. Ritieni che si tratti di un esito sostanzialmente fisiologico, data la presenza di vari elementi del Canzoniere del Lazio? Gl’influssi di quel genere, evidenti anche nel disco solo di Mauro Pagani, sono da ritenersi un’evoluzione naturale del prog italiano o per il loro tramite si è andati alla ricerca di nuove possibilità espressive per un genere forse giunto a una fase di stallo, complice anche l’enorme dispendio d’ispirazione e creatività che ne ha caratterizzato la fase precedente e un po’ tutto il percorso?
E’ un discorso complesso. Carnascialia nasce direttamente da una costola del Canzoniere, e l’idea di Pasquale Minieri (principale mente del progetto) fu di coinvolgere i musicisti più in vista di una certa area “alternativa” (e diciamo pure politicizzata) italiana, come alcuni membri degli Area (che avevo già conosciuto a prescindere) o Mauro Pagani. Come nel gruppo precedente c’era parecchio spazio dedicato all’improvvisazione. Una summa, insomma, di quello che girava negli anni 70: ritmiche rock-folk, temi semplici e cantabili di orientamento popolare, ma anche lunghe tirate modali di coltraniana o davisiana memoria. E’ un minestrone che all’epoca mi lasciava perplesso, ma bisogna riconoscere che è stata un’esperienza assolutamente originale e unica. Ho recentemente ascoltato alcune registrazioni live dell’epoca e mi sono emozionato.

Andiamo ancora avanti di qualche anno per arrivare ai Lingomania, forse il gruppo più in vista della fusion italiana, per quanto detesti quel termine e ritenga sia più corretto parlare di jazz elettrico o contemporaneo. Vorrei se possibile una tua valutazione riguardo alle origini del gruppo, alla sua parabola artistica e poi alla sua fine, forse prematura. Quali potevano essere, eventualmente e a tuo giudizio, sue ulteriori possibilità di evoluzione?
Beh, un gruppo che si identifica con un nome si porta dietro l’estetica del rock e della condivisione di intenti fra i suoi membri, anche se suona, come giustamente hai puntualizzato, del jazz elettrico. La fortuna di Lingomania è stata quella di essere formato dalla crema dei musicisti dell’epoca (tutti grandi amici che avevano già suonato insieme in molti progetti), e che gli altri due compositori del gruppo, Pietropaoli e Fiorentino, scrivevano nello stesso stile in cui scrivevo io. E’ sicuramente stato il passaggio alla piena maturità per tutti noi, e il gruppo ha fatto storia. Lingomania ha sofferto di un problema strutturale italiano: la mancanza di spazi adeguati per fare quella musica. Avremmo dovuto fare un salto di qualità molto complicato portandoci dietro fonica e fonici e suonando in spazi più grandi, ma non c’erano i numeri per quel tipo di musica, e non avevamo intenzione di cambiare. La situazione non solo non è cambiata, semmai è peggiorata. Il jazz elettrico lo si può fare solo nei grandi festival.
Proprio negli anni in cui Lingomania era all’apice della sua attività, si è avuto quello che si potrebbe definire “fenomeno Grolnick” in funzione del quale il pianista e tastierista fondatore degli Steps ha avuto un seguito rilevante, a livello di musicisti ancor più che di pubblico. Del resto nel secondo e soprattutto nel terzo LP di Lingomania mi è sembrato di rilevare affinità con “Hearts and Numbers”, primo album di Grolnick da solista. Dunque ti chiedo, se possibile, una tua valutazione personale e soprattutto un’analisi di quel fenomeno, proprio dal punto di vista del musicista, sia pure attivo principalmente su un altro strumento. In particolare riguardo alle sue motivazioni: se da ascoltatore sono ben conscio di quel che mi porta ad ascoltare Grolnick, traendone tuttora grande piacere, ritengo interessante capire meglio la posizione di chi opera nell’ambito della creazione e produzione della musica.
Considero “Hearts And Numbers” per quanto mi riguarda, il disco migliore del periodo: quello che ha nobilitato tutta la fusion degli anni 80, con musica di grande poesia e artisticità. E’ stato sicuramente un disco che ha esercitato una grande influenza nel mio modo di scrivere, per la semplice ragione che la mia testa andava nella stessa direzione e con lo stesso background (fattore importante). Se hai notato affinità non le nascondo certo, anzi mi fa piacere.
Riguardo al jazz che si suona oggi, mi sembra di rilevare una certa carenza, un atteggiamento rinunciatario persino, riguardo alle possibilità di ulteriore evoluzione, elemento fondamentale per qualsiasi forma d’arte, alla ricerca di nuove modalità espressive e persino, volendo, a una certa visionarietà. Venute a mancare le figure guida che durante gli scorsi decenni hanno svolto una funzione essenziale a questo riguardo, ritieni sia ancora possibile lo sviluppo di nuove forme lessicali o altrimenti sia inevitabile il rassegnarsi a eseguire, e ad ascoltare standard, eventualmente con variazioni sul tema, ma sempre legate a una certa ortodossia? Dal punto di vista dell’artista, in fondo, non potrebbe crearsi una certa stanchezza o solo abitudinarietà, tale da limitare o persino inibire già di per sé slanci indirizzati alla diversificazione e alla ricerca di forme nuove di creatività ed esecuzione? In condizioni come queste, quale può essere il futuro del genere musicale conosciuto come jazz?
Domanda molto complessa. Il livello dei musicisti è enormemente cresciuto e in tutto il mondo, per cui è difficile che emergano “maestri” del livello dei padri o dei nonni. Le forme e i territori espressivi sono stati veramente esplorati in lungo e in largo e il jazz risente di forti personalismi, almeno da quando siamo entrati nel post-modernismo (cioè dagli anni 70!). Dunque non mi riferisco a certo jazz di maniera che si continua comunque a fare perché, se fatto bene, è comunque musica piacevole. il jazz più interessante è ormai una musica difficile che richiede un pubblico preparato e spazi adeguati. Insisto su un concetto già espresso prima, la musica non la fanno solo i musicisti, ma anche i gestori, gli spazi, i media, eccetera. E l’attenzione verso questa musica è a livelli semplicemente disastrosi, particolarmente in Italia ma in realtà dappertutto. Il paradosso è che invece le scuole di musica sono piene di ragazzi che vogliono suonare. Dove?

Quali sono gli artisti ai quali ti senti idealmente più legato o a cui riconosci comunque un ruolo nei tuoi confronti a livello ispirativo?
Io sono prima di tutto un grande appassionato e ho una discoteca “molto” fornita. Ho sempre sentito e sento ancora di tutto. Se la musica è sincera, ispirata e onesta in genere trova la mia attenzione. Da quando avevo 10 anni i miei gusti si sono evoluti gradualmente in varie direzioni. Il sassofonista che ho studiato di più è probabilmente Sonny Rollins, ma non significa granché, perché mi piacciono più o meno tutti.

Quali sono gli album a tuo nome o a cui hai collaborato che ritieni più significativi per approfondire la conoscenza della musica da te composta ed eseguita nel corso degli anni?
I miei dischi preferiti sono sempre gli ultimi. Ma avrei molto da dire anche su quelli….
Se lo ritieni opportuno, credo sia interessante parlare dei progetti che stai portando avanti attualmente.
Il gruppo Syncotribe che suona in versione trio o quintetto e un quartetto internazionale pianoless col quale ho pubblicato da poco Past Present per l’Auditorium. Ho anche musica per organici più grandi, ma è molto difficile da realizzare.
Per finire vorrei chiederti una valutazione riguardo alle nuove modalità di distribuzione della musica, quelle che avvengono per mezzo della rete e di siti come Tidal, Spotify e similari, in particolar modo nei riguardi dei loro effetti sul settore della composizione e della produzione musicale, oltreché sulle possibilità di mantenere una professionalità concreta nell’ambito musicale.
E’ cambiato tutto ovviamente, e il dato più evidente è che non si ha alcun tipo di controllo sulle piattaforme digitali, che si arricchiscono alle spalle dei musicisti dando una miseria di royalties ai medesimi, se per caso le danno. La situazione è particolarmente disastrosa per le musiche di nicchia, perché tra l’altro non si vendono più dischi. Questa musica sarà in futuro un hobby da ricchi, o potrà sopravvivere solo con i finanziamenti pubblici, quindi sarebbe anche interesse dei contribuenti ridare fiato al mercato musicale bloccando le piattaforme digitali (e risparmiare nel settore finanziamenti). Ma chi glielo spiega?

Qui le parti si capovolgono ed è l’intervistatore che risponde alla domanda dell’intervistato. Ho pubblicato alcuni articoli a questo riguardo, le cui argomentazioni sono in linea con quelle di un musicista del calibro di Maurizio Giammarco. Segno che chi ama davvero la musica la vede alla stessa maniera.
Dunque ne allego i link, non prima di aver ringraziato Maurizio per la sua disponibilità e soprattutto per le notizie che ci ha fornito, tali da permettere uno sguardo inedito verso realtà musicali oggi leggendarie e più in generale di comprendere il punto di vista dell’artista, non sempre facile da intuire sedendo da questa parte degli altoparlanti.
Liquida e streaming, questione di comodità
Liquida e streaming, questione di comodità 2
Musica “liquida”, il vero significato
Liquefare l’analogico? No, grazie
Cambiare il pick up laser, prendere un altro lettore e le possibili alternative
Maurizio Giammarco suonerà insieme al suo quintetto Halfplugged Syncotribe, il 14 aprile prossimo alla Casa del Jazz di Roma.
La formazione vedrà all’opera insieme a Giammarco Luca Mannutza al piano, Enrico Morello alla batteria, Paolo Zou alla chitarra e Makar Novikov al basso.
Il prezzo del biglietto è di 15 euro: inverosimile quando per farti vedere da un chilometro di distanza dei pupazzi ammaestrati che fanno finta di suonare, male oltretutto, ti chiedono centinaia di euro. Giustamente il playback, con tutto il macchinario che comporta specie se eseguito dal vivo, ha i suoi costi.
La musica buona e vera costa poco e non se la fila nessuno, quella finta costa un’enormità e il pubblico va in visibilio.
Nulla di strano, in questo mondo capovolto.