Per quanto il rock progressivo sia una forma espressiva, meglio un movimento musicale che in genere si fa risalire agli anni 1970, in realtà alcuni tra i suoi gruppi più rappresentativi avevano già concluso la loro traiettoria artistica, o comunque la parte più significativa di essa, già agli inizi di quel decennio.
Tra di essi ci sono i Colosseum e i Van Der Graaf Generator, gruppo cui è dedicato questo articolo.
Quella era l’epoca dei nomi lunghi, tra i quali ricordiamo anche la Premiata Forneria Marconi e il Banco del Mutuo Soccorso, Erano certo suggestivi ma finivano regolarmente per essere abbreviati. Così ci si riferiva alla Premiata, al Banco e ai Van Der Graaf, che in genere sulla carta stampata si riassumevano nell’acronimo VDGG.
Oggi, forse, i Van Der Graaf Generator non hanno la considerazione e la popolarità che si attribuiscono ai capiscuola del genere, come i King Crimson o i Gentle Giant, ma all’epoca erano considerati a un livello almeno pari del gruppo di Robert Fripp e per più di qualcuno erano addirittura superiori. Non a caso lo stesso Fripp ha fatto da ospite almeno in un paio dei loro dischi.
La fase più interessante della loro storia è appunto quella che va dal 1968 al 1971, cui venne a suo tempo dedicata una raccolta pubblicata l’anno successivo, il 1972, come a sancire il suo completamento.

Quello fu anche l’anno in cui uscì l’ultimo album della fase in questione, “Pawn Hearts”. La formazione era ridotta a un quartetto, stante l’abbandono del bassista Nic Potter, fuoriuscito qualche tempo prima, che non fu sostituito. L’esecuzione delle linee del basso venne affidata pertanto alla pedaliera dell’organo di Hugh Banton. Il resto della formazione comprendeva Peter Hammill, voce e chitarra, David Jackson ai sassofoni e flauto, Guy Evans alla batteria.
Il disco era stato registrato nel corso del 1971 e finì addirittura in cima alla classifica italiana degli LP, posizione in cui rimase per alcune settimane. Si è trattato di qualcosa di assolutamente inusuale, per il mercato italiano e per la musica eseguita dal gruppo, cui si può attribuire ogni definizione tranne quella di essere roba da classifica. Eppure andò così, forse anche perché in quella fase agli LP si rivolgeva una clientela piuttosto particolare, mentre la gran parte del pubblico generalista era interessata soprattutto ai 45 giri.
Fosse uscito soltanto l’anno successivo, con ogni probabilità “Pawn Hearts” in cima alla classifica non ci sarebbe arrivato, ma del resto nell’ambito della musica moderna la tempestività di pubblicazione ha da sempre un ruolo imprescindibile.
Nel 1973, d’altronde, i Van Der Graaf, almeno nella loro edizione originaria, non c’erano già più. Consumati, secondo la testimonianza dei musicisti che ne facevano parte, dalle fatiche delle tournée e della vita sulla strada, oltreché dalle angolosità caratteriali di alcuni componenti del gruppo, destinate a salire in superficie proprio nei momenti più stressanti.
Quanto detto fin qui basta a comprendere, e a giustificare, che i Van Der Graaf siano stati uno tra i gruppi inglesi che ha avuto più successo in Italia che in madrepatria. Altro esempio di questa realtà sono stati i già menzionati Gentle Giant, i dischi dei quali da un certo punto in poi uscirono addirittura prima da noi che in Inghilterra, gli Henry Cow e alcuni altri.
Il legame che riuscirono a instaurare col pubblico, malgrado l’indubbia difficoltà della loro musica, fu tale che anche dopo il loro scioglimento gl’impresari italiani continuarono con grande insistenza a proporre serie di concerti in cui esibirsi. E quando si faceva notare che il gruppo non esisteva più, rispondevano che non faceva niente, sarebbero bastati giusto un paio dei componenti originari, sostituendo gli altri come possibile. Bastava insomma che si potessero annunciare i Van Der Graaf Generator, quanto a proposito interessava fino a un certo punto.
Oggi non ci si farebbe sfuggire l’occasione, ma all’epoca i componenti del gruppo declinarono gl’inviti, reiterati più e più volte.
Una delle loro ultime serie di concerti di quella fase storica annovera tra le altre la serata che si tenne al Piper Club di Roma. Ad essa ero presente anch’io, malgrado non avessi compiuto ancora quattordici anni. Era il Febbraio 1972 e il biglietto costava 1500 Lire, circa la metà di un LP, che diventavano 1200 per tutti i possessori del tagliando sconto pubblicato su Ciao 2001, a quel tempo la più in vista delle pubblicazioni che s’interessavano di musica rock.
Quello infatti è stato un concerto come pochi altri ne ho visti, malgrado sia stato tra il pubblico di alcune centinaia di essi.
L’apertura fu affidata a “Il Ritratto di Dorian Gray”, il trio di batteria, basso e tastiere capitanato da Claudio Simonetti, prima che formasse i Goblin, in cui figurava anche Walter Martino, figlio del cantante Bruno. La loro esibizione fu piuttosto lunga e quando terminò si era già esausti. Il Piper era stracolmo e, per farci entrare tutti, dal parterre si erano eliminate le sedie, costringendo il pubblico a stare seduto sul pavimento, stretto come in una scatola di sardine. Il solo riuscire a trovare una posizione in cui resistere per più di qualche minuto non era cosa facile.
Il concerto dei Van Der Graaf, comunque, fu incredibile. Erano già nella formazione priva del basso elettrico, per cui voce, organo, sassofoni e batteria svettavano in maniera particolare nei confronti di uno sfondo vuoto in maniera fin quasi innaturale, conferendo al suono del gruppo una connotazione molto particolare e suggestiva.
All’epoca inoltre ogni strumentista aveva la propria amplificazione e il cantante il suo “impianto voci”. Quelli usati dai van Der Graaf erano di produzione Wem, distinguibili dal marchio a grandi lettere colorate di rosso. Non esisteva ancora il concetto del controllo integrale dei segnali provenienti dal palco attraverso un mixer che poi inviasse il segnale ai diffusori come in un gigantesco impianto stereo, o comunque non aveva ancora trovato spazio in “piccoli” concerti come quello che stiamo rievocando. Quindi se da un lato era più difficile ritrovare ogni volta il giusto equilibrio tra i livelli dei diversi strumenti, aspetto influenzato anche dalle caratteristiche architettoniche e acustiche del locale in cui avveniva l’esibizione, dall’altro la sensazione di separazione tra le rispettive sonorità era per forza di cose più netta nei confronti di quello cui siamo abituati oggi.
Il concerto fu lunghissimo e si aprì con “Squids”, brano che figurava nel primo album attribuito ai Van Der Graaf, “Aerosol Grey Machine”, ma che in realtà è più che altro un disco di Peter Hammill. Per lunghi anni rimase introvabile, fino alla prima ristampa su etichetta Vertigo, di cui qualche copia arrivò anche da noi.

La versione dal vivo di “Squids” era tuttaltra cosa rispetto al brano pubblicato su disco e già all’apertura del concerto pose in evidenza l’attitudine del gruppo ad ampliare in maniera fin quasi imprevedibile ciascuno dei brani, ma senza che per questo risultassero vuoti, ripetitivi o stucchevoli. Le sonorità spaziali dell’organo di Banton, quelle dei sassofoni di David Jackson, spesso suonati a due alla volta e sottoposti al trattamento di elettrificazione e distorsione fin quasi a renderli irriconoscibili, erano qualcosa d’incredibile. Lo sono ancora oggi, figuriamoci cosa potevano essere nel 1972, epoca in cui radio e TV passavano Gianni Morandi e Orietta Berti, mentre il massimo dell’avanguardia per le persone “normali” erano I Nuovi Angeli.
Quelle sonorità, unite alla voce straniante e quasi sempre sopra le righe di Peter Hammill davano luogo a una mistura che solo dopo averla ascoltata se ne poteva comprendere la forza espressiva e nello stesso tempo il potenziale innovativo, che non avrebbe trovato più nulla in grado di riprenderne le peculiarità. Era qualcosa d’irripetibile, tanto è vero che anche le versioni successive della formazione non poterono avvicinarsi neppure alla lontana alla forza del repertorio di quegli anni.
Senza voler assolutamente ricadere nell’abuso di superlativi tipico dei recensori di ogni materia, la musica suonata in quel periodo dai Van Der Graaf era semplicemente ai confini della realtà. Andava oltre ogni limite e definizione, soprattutto in termini di genere e trovava seguito innanzitutto perché non si preoccupava di piacere. Per comodità la si catalogava nell’ambito del rock, ma in realtà aveva poco o nulla a che fare con esso, in particolare con le sue forme più usuali. Illustrava come meglio non si potrebbe l’attitudine del progressive a fare dell’assenza di regole e limiti stilistici ed espressivi la sua regola numero 1.
Era una musica di grande libertà, spinta a un livello oggi persino inconcepibile, che per forza di cose influenzava la visione e le prospettive di chi ne andava a esplorare non del tutto superficialmente i contenuti. Per musica simile, del resto, l’ascolto superficiale non era proprio possibile.
Questa fu la grande forza e insieme il limite primario del rock progressivo. Quanto a lungo si poteva reggere a livelli simili di creatività e innovazione? Fin quando si sarebbe potuto, già a livello fisico, sostenere il dispendio di energie necessario a esprimersi su quei livelli, oltretutto sera dopo sera, nel corso di tournée già di per se sfiancanti dal punto di vista strettamente logistico?
E poi a livello di creatività come mantenere in pratica, e in forma continuativa, il tasso ispirativo necessario alla trasformazione inarrestabile che ha caratterizzato il rock progressivo, espressa oltretutto su piano di lontananza siderale da tutto quanto si fosse mai ascoltato fino ad allora e per mezzo di brani che assomavano in ciascuno di essi un numero di idee che in altre situazioni sarebbero bastate per un intero o album o forse due?
Quando la fiamma brucia con tale intensità, è inevitabile che consumi a velocità inverosimili qualsiasi cosa la possa alimentare. Così, nel giro di qualche anno tutto sarebbe finito. E gl’innumerevoli tentativi di riesumazione di quel genere musicale non avrebbero potuto che essere ancor meno di una pallida imitazione di quello che è stato il vero rock progressivo, risultando oltretutto fuori contesto già a livello compositivo e di esecuzione.
E’ per tutti questi motivi che dal concerto del Piper ho tratto un imprinting che ha avuto un ruolo fondamentale nella mia formazione di appassionato di musica e poi di riproduzione sonora.
Quello del locale di Via Tagliamento è stato forse il momento migliore per i concerti che si sono tenuti nella Capitale. Erano ancora roba per pochi intimi, non più di qualche centinaio di persone alla volta, e quindi molto più a misura d’uomo e di appassionato, rispetto agli eventi delle stagioni successive che si sarebbero tenuti al Palasport.
A parte l’acustica totalmente inadeguata di una costruzione il cui vero scopo sembra soprattutto l’autocelebrazione del suo ideatore e progettista, in cui il rimbombo la faceva da padrone e oltretutto con ritardi siderali rispetto all’emissione primaria, pressoché privi di attenuazione progressiva del loro livello acustico, veniva meno proprio il contatto ravvicinato tra pubblico e artisti, che diventavano qualcosa di reciprocamente estraneo, tale da rendere ben più asettiche le esibizioni. Anche in quella sede si sarebbero tenuti concerti memorabili, tuttavia l’atmosfera raccolta e partecipata del Piper era ben altra cosa, che si sarebbe perduta per sempre. Causa prima, il successo fon troppo grande di qualsiasi concerto si organizzasse e l’assenza di luoghi più adeguati allo scopo
Nella serata che stiamo rievocando il gruppo ripercorse i brani migliori del suo repertorio, da “Lost” a “Killer”, a “Darkness” e tutti gli altri. Al bis fu “Theme One”, che all’epoca non figurava ancora nella sua discografia, Sarebbe stato pubblicato in seguito su 45 giri, per comparire poi nelle edizioni statunitensi di “Pawn Hearts” come secondo brano della prima facciata, spaccandone di fatto l’integrità compositiva.
Ai concerti dei Van Der Graaf Generator, insomma, gli anni 70 ruggivano, nel vero senso della parola.
Inevitabile, dopo quel concerto, acquistare i dischi del gruppo pubblicati fino ad allora: a parte quello d’esordio menzionato sopra erano “The Least We Can Do Is Wave To Each Other”, del 1969, “H To He: Who Am The Only One”, 1970 e il già menzionato “Pawn Hearts”, 1971. Date che stanno a significare come i Van Der Graaf fossero molto avanti rispetto alla loro epoca e forse persino troppo. In ognuno di quegli album sono presenti alcuni tra i brani eseguiti in quel concerto leggendario. In nessuno di essi però sono riuscito a ritrovare sia pur vagamente la sonorità che tanto mi aveva colpito quella sera.

Inizialmente diedi la colpa al mio impianto, che allora era quello che era. Anche in seguito comunque non c’è stato verso. Solo in epoca recente sono riuscito a riascoltare qualcosa capace di riportarmi a quel suono incredibile e indimenticabile: in una riedizione recente su CD di “H To He” fra le tracce aggiuntive c’è “Squids”, brano di apertura di quel concerto, proprio in una ripresa dal vivo, eseguita dalla formazione senza basso. Al volume giusto e con il giusto impianto permette finalmente di ritrovare la sonorità che ho atteso per qualche decennio.
Quella sera, anzi ormai era notte fonda, per la prima volta in vita mia ho sperimentato la sensazione di sconforto, di vera e propria desolazione che in tanti anni avrei riprovato pochissime volte ancora, tipica dei momenti immediatamente successivi alla fine dei concerti più coinvolgenti.
La sua parte più fisica assomiglia a ciò che si proverebbe dopo che ti è passata sopra una schiacciasassi. Finita la musica, è come se ti avessero portato via un pezzo del tuo corpo o della tua mente. Più niente sembra avere importanza e tutto appare irrimediabilmente banale.

Poi col passare delle ore, e talvolta dei giorni, ci si riacclimata con la quotidianità, ma il ricordo della forza della musica e delle sensazioni prodotte nel suo ascolto in condizioni simili non solo si fissa in maniera indelebile ma produce un cambiamento profondo in termini di gusti, prospettve e almeno per quanto mi riguarda capacità di accettazione per tutto quanto non caratterizzato da un tasso artistico e di creatività che possa reggere di fronte a simili pietre di paragone.
In base a conderazioni di questo genere si spiega anche perché l’industria discografica abbia fatto di tutto per sbarazzarsi del progressive, chiudendogli di fatto tutti i varchi non appena ha iniziato a mostrare i primi segni di stasi creativa. O forse il rapporto di causa-effetto è stato inverso, chissà.
Musica di tale spessore rovinava la piazza, viziando malamente il pubblico, che poi per forza di cose trovava difficoltà ad accettare l’immondizia a costo zero che gli si voleva propinare.
Ecco perché gran parte del pubblico che ha avuto la possibilità di acquisire la sua formazione col progressive, nel momento in cui su di esso si è voluto calare il sipario ha abbandonato proprio la musica rock.
In un certo senso, quindi, il punto di vista dell’industria discografica non era del tutto ingiustificato.
Del resto punk, new wave, il commercial-banalotto cui si sono dati vari gruppi che prima vevano suonato il rock progressico e peggio che peggio la disco-music che ad esso hanno fatto seguito risultavano semplicemente inascoltabili per chiunque avesse seguito il prog non per moda ma comprendendone o solo apprezzando col minimo di consapevolezza i motivi d’essere.

Di occasioni per riascoltare i Van Der Graaf dal vivo ce ne sarebbe stata più di qualcuna. La prima fu allo Stadio Flaminio, preceduti da Arthur Brown. In realtà si trattò di un’esibizione solitaria di Peter Hammill, che eseguì il suo allora nuovo album solo, tutto di voce e chitarra, “Chameleon In The Shadow Of The Night”. Si è trattato forse di una forma di reazione allo sforzo profuso durante gli anni precedenti, anche se in realtà la sua musica non si ammorbidì assolutamente, tuttaltro. Solo nel brano finale del concerto, “Rock And Role”, salirono sul palco gli altri tre membri del gruppo.
Inevitabile uscire da quel concerto con una grande delusione.
Poi ci fu un’altra occasione, a Villa Pamphili, in occasione di quella che è stata forse l’edizione più bella del festival omonimo e purtroppio l’ultima. Era il 1975. I Van Der Graaf suonarono dopo il Banco che eseguì anch’esso un concerto stupendo, e aprirono con “Darkness”, titolo che fu annunciato così, in maniera cruda, semza preamboli o altro.
Ascoltare la loro musica all’aperto, nell’aria tiepida di una notte settembrina e con intorno lo scenario della Villa è stata un’altra di quelle esperienze che non si dimenticano facilmente. Erano passati già più di tre anni dalla sera del Piper, eppure la loro musica ha avuto la stessa presa di allora e forse di più. I Van Der Graaf quella sera suonarono in maniera eccezionale. E purtroppo per il repertorio storico del gruppo sarebbe stata l’ultima volta, almeno per me.
La sera dopo suonarono i Soft Machine, con Allan Holdsworth in formazione, altro argomento di cui prima o poi sarà necessario parlare.
Ora però vorrei tornare per un istante a David Jackson e alla sonorità dei suoi sassofoni, distintiva di quell’epoca, di grande inventiva e libertà.
Allora non c’erano i banchi sterminati di suoni offerti dalla sintesi digitale, apparentemente in grado di attribuire allo strumentista la massima libertà di scelta, ma in realtà castranti per la loro pochezza, essendo generalmente improntati a una grande banalità e a una sostanziale standardizzazione, oltretutto sulla base di un’evidente povertà spettrale. Però sono facili da ottenere, allo scopo basta la pressione di un pulsante.
In epoca prog se volevi la sonorità particolare te la dovevi inventare. Per mezzo dell’elettrificazione e poi del passaggio attraverso distorsori, wah-wah e il resto di quel poco che la tecnologia offriva all’epoca, di derivazione strettamente analogica. Nondimeno ne risultavano sonorità di grande personalità e impatto, soprattutto nella loro applicazione agli strumenti a fiato. Come appunto quelle di David Jackson, la cui derivazione da sassofoni a volte era riconoscibile solo a prezzo di grandi difficoltà. Lui stesso del resto dichiarava di fare cose che gli era stato detto di evitare e proprio da quello derivava le sonorità così inusuali che gli valsero l’apprezzamento del pubblico.
Al punto che lui stesso ricorda quando dal pubblico italiano veniva inneggiato al grido di Jackson – Jackson… come un giocatore di calcio o simili.
Del resto proprio quella era una delle prerogative di fondo del progressive, stante appunto nelle sonorità particolari e distinguibilissime di ognuno tra i gruppi più in vista del genere. Al confronto, i suoni preconfezionati dell’era digitale sembrano davvero poca cosa, anche quando l’avvento dei sistemi a campionamento è sembrato attribuire al settore prospettive prima inconcepibili.
Malgrado tanto dispendio tecnologico si è rimasti sempre su suoni magari sorprendenti al primo impatto ma che poi diventano in breve stucchevoli, proprio per via della loro origine e dell’incapacità di pervenire a un contenuto spettrale tale da soddisfare l’orecchio più a lungo di qualche breve istante.
Non solo, ciascuno tra i suoni che è andato di moda in un dato momento, oggi risulta tale da connotare temporalmente nel modo più immediato il brano di cui fa parte. Viceversa i suoni di origine analogica, sia pure a tanti anni di distanza, restano non solo ineguagliati ma soddisfacenti e per questo oggetto di un costante recupero.
Non a caso piano Fender, organo Hammond e sintetizzatori analogici come il Minimoog per un certo periodo non li ha voluti più nessuno, ma ormai da quasi due decenni vengono disputati a peso d’oro e i fabbricanti di strumenti si affannano a realizzare qualcosa che abbia una sonorità tale da rassomigliare ad essi in qualche modo, anche se in genere si tratta di un’imitazione pallida.
In sostanza, allora, anche nell’ambito degli strumenti musicali si è percorsa una traiettoria del tutto simile a quella che abbiamo avuto nell’audio amatoriale, con l’analogico prima buttato alle ortiche e poi dimenticato per due decenni. In seguito lo si è recuperato e oggi abbiamo finito col pagarlo cifre improbabili.
Ecco uno tra i motivi per cui la musica degli anni 70 suona più fresca e attuale di quella dei decenni successivi, irimediabilmente segnata dai suoni preconfezionati e comunque artefatti che di essi sono tipici e ne rendono immediatamente riconoscibile il prodotto.
A questo d’altronde porta la tecnologia: pur consentendo l’accesso a una quantità di suoni molto ampia e con grande facilità, non può per forza di cose confrontarsi con quel che usciva dagli strumenti dei tanti capiscuola, che erano tali anche nella sperimentazione di sonorità inedite e tra i quali figurava appunto un musicista del calibro di David Jackson.
Oggi d’altronde tutto deve essere cotto, mangiato e poi consumato con la massima fretta. Allora certi suoni erano il frutto di mesi e forse anni di prove, sperimentazioni ed evoluzioni, da parte di gente che aveva imparato sulla sua pelle dove andare a mettere le mani e che non si sarebbe accontentata di spingere banalmente un pulsante e di quanto possa derivarne.
Sono tanti del resto gli strumenti che cercano di scopiazzare le sonorità di allora, che però non c’è verso di rifare per quello che erano. Proprio perchè le loro origini sono incompatibili coi metodi sintetici di produzione del suono oggi in auge.
Soprattutto, all’epoca c’era una prospettiva. Avrebbe mancato di raffigurare sia pure parzialmente la realtà dei periodi successivi in maniera di sicuro clamorosa, ma quantomeno esisteva e lasciava immaginare uno sviluppo, per quale che fosse. Oggi invece, quello che ci viene promesso è un destino di segregati, controllati fin nei meandri più reconditi della nostra attività e personalità, solo perchè un branco di psicopatici dalla tendenza alla criminalità più efferata hanno preso il controllo del pianeta e deciso di fare del controllo totale l’elemento primario dell’accumulazione di profitti che si prefigge ed esige sia di proporzioni incalcolabili.
Nemmeno la musica proiettata con maggiore determinazione al futuro, proprio come quella dei Van Der Graaf Generator, sarebbe stata in grado di farci immaginare una distopia tanto spinta alle conseguenze più estreme della disumanità.
Un certo Pete Sinfield tuttavia, proprio alla fine degli anni sessanta ha scritto il testo di un brano profetico che s’intitola “L’uomo schizoide del 21mo secolo”.
Ne riparleremo.




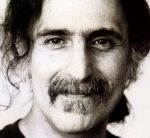


Ciao Claudio,
un altro bell’articolo per un gruppo forse non conosciutissimo come altri, ma con del talento da vendere. Condivido in pieno le tue considerazioni, la prima volta che mi avvicinai a Pawn Hearts ebbi prima una sensazione di straniamento, perplessità, evolutasi in inquietudine e senso di solitudine. Sicuramente uno dei miei album preferiti in assoluto! Senza poi dimenticare la copertina, così ermetica ma al tempo stesso affascinante e piena di dettagli, che si colgono soltanto nella versione a 33 giri.
In merito a quello che è venuto dopo il progressive, e più in generale agli anni ’80, sono meno perentorio, ci sono diversi gruppi e album comunque meritevoli di attenzione. Certo, tutto ciò che si è sfornato negli anni ’70 è qualcosa di irripetibile, e su questo non ci piove. Il fatto che gruppi di un certo spessore, come il Banco o i Genesis abbiano poi pubblicato album finiti nel dimenticatoio, è un dato di fatto, ma è anche vero che gli artisti hanno bisogno di esprimersi secondo quello che sentono di dire al momento, anche sperimentando i nuovi mezzi che la tecnologia propone.
Infine, l’attuale panorama musicale, seppur desolante, propone piccole gemme meritevoli di ascolto: si tratta per lo più di gruppi sconosciuti ai più, con tirature contenute, ma comunque interessanti. Mi viene in mente ad esempio il disco d’esordio de “Gli ingranaggi della valle”, dove tra l’altro è presente anche un cameo di David Jackson.
Alla prossima
Ciao Alberto,
grazie dell’apprezzamento.
Sono perfettamente d’accordo con te su tutta la prima parte del commento. Invece per quanto riguarda gli album finiti nel dimenticatoio, personalmente li ricordo benissimo. Preda della banalizzazione forzata post-prog, genere al quale resto convinto lo stop sia calato dall’alto per motivi che non riguardavano soltanto le questioni discografiche, non penso proprio fossero il frutto dello stato d’animo dei musicisti in quella fase, ho troppa stima della maggior parte di loro. Ritengo invece siano stati la risultante delle pressioni cui li si è sottoposti. Troppa infatti è stata la sincronia con cui hanno saltato la barricata un po’ tutti, tranne gli Area a loro merito ulteriore. Col senno di poi sarebbe stato molto meglio restassero in silenzio, piuttosto che produrre quella robaccia, andata a insozzare le loro discografie e per forza di cose le loro carriere. Oltretutto quei dischi non li ha comperati nessuno, la loro sola utilità è stata quella di amplificare uno stato di crisi trasformandolo in tonfo, coaì da giustificare uno stop che si è voluto far passare per ineluttabile ma che invece si esigeva e quindi lo si è perseguito con tutti i mezzi. D’altronde in certi ambienti è quella la norma: non si ha mai il coraggio di esprimere apertamente i propri pensieri e desideri, ma si briga a livello sotterraneo affinché si avverino e puntualmente ci si riesce, stante il pieno controllo dei mezzi necessari allo scopo. La storia recente ha proposto più e più volte accadimenti materializzatisi in base a quelle logiche e a quei meccanismi, salvo poi tacciare di complottismo chi ha la capacità di leggerli per quello che in effetti sono stati e di riconoscerne almeno in parte le vere cause e finalità.
Piuttosto che dire baggianate, meglio restare in silenzio. Tantopiù quando di fatto si viene costretti a rendersi complici di certe azioni. Che siano il taglio repentino del prog, solo e vero motore del passaggio della riproduzione sonora di qualità da realtà di nicchia per pochi facoltosi a fenomeno di massa, o l’uccisione dell’analogico, tanto per parlare di due tra gli avvenimenti che hanno segnato maggiormente il settore di nostro interesse, fa poca differenza o meglio nessuna. Alla prossima.